Discorsi
Emma BONINO - Deputato Opposizione
VIII Legislatura - Assemblea n. 286 - seduta del 25-02-1981
1981 - Governo Forlani - Legislatura n. 8 - Seduta n. 286
- Attività legislativa
devo dire che ero molto contenta di svolgere questo intervento, perché avevo visto seduto sul banco del Governo , durante le votazioni, il ministro dei lavori pubblici e mi interessava molto illustrare questi articoli aggiuntivi alla sua presenza per approfondire in questa sede anche alcuni scambi di vedute intercorse con lui questa mattina; spero, quindi, che si trovi nelle vicinanze dell' Aula e rientri quanto prima. abbiamo presentato questa serie di articoli aggiuntivi perché riteniamo che la mancanza assoluta, nella legge finanziaria ed anche nel bilancio, di un capitolo specifico relativo all' assetto idrogeologico del territorio non sia tollerabile in termini di programmazione di politica economica . interrompo la mia esposizione per un momento, presidente, per lasciare defluire i colleghi. dicevo che nel disegno di legge finanziaria non sono previsti stanziamenti specifici per l' assetto idrogeologico del territorio. sono fissati solo, alla voce fondi globali, 300 miliardi per l' anno 1981, 500 miliardi per l' anno 1982 e mille miliardi per il 1983. è poi fissato uno stanziamento nel disegno di legge finanziaria, che credo sia degno di nota in quanto abbastanza ridicolo: per le esigenze del servizio geologico è stata fissata la somma eccezionale di 12 milioni per il 1981 e di altrettanti per il 1982 e il 1983. immagino che il servizio geologico dello Stato italiano abbia bisogno di un usciere e non di altro perché, signor presidente , lei capirà che con 12 milioni annui difficilmente si riesce in termini globali ad assumere un usciere. questo modo di procedere in termini politici rispetto a questo problema non è, peraltro, una novità. si è sempre agito così negli ultimi anni e il mio intervento varrà proprio a dimostrare come, nonostante i ripetuti appelli, i ripetuti dati, le indagini conoscitive , e cose del genere , esperite peraltro o dal Governo o dal Parlamento, che hanno prospettato piani o esigenze di piani decennali o quinquennali, tutto ciò sia rimasto letteralmente lettera morta e completamente inevaso. se guardiamo, ad esempio, come si è proceduto in termini legislativi rispetto al problema del territorio o della difesa del suolo, vediamo che siamo in realtà fermi ad una legislazione quasi umbertina. se guardiamo al modo di procedere ci accorgiamo chiaramente che ci si è sempre comportati alla stessa maniera. grandi alluvioni, ad esempio: « leggi tampone » . basta ricordare le date dei grandi avvenimenti, dei disastri meteorologici del nostro territorio, per capire che si è sempre proceduto sull' onda dell' emozione momentanea per tamponare a vari livelli i danni economici, e non solo economici, che questi disastri ecologici avevano procurato. ma tutte le volte che si è cercato di definire una visione di insieme o un piano minimamente decente, si è anche avuto un piano che poi non è stato finanziato. credo che molti ricordino la grande alluvione del 1951, con lo straripamento del Po: a questo disastro probabilmente dobbiamo una delle prime leggi decenti sul problema, la legge numero 184 del 1952, che per la prima volta prevedeva un piano triennale per l' assetto idrogeologico del territorio. nella relazione di questo piano orientativo era detto che il ministro dei lavori pubblici , d' intesa con quello della agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dalla data della legge (19 marzo 1952, a meno di un anno dall' inondazione del Polesine), avrebbe presentato un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa dei corsi d' acqua naturali, nell' intero territorio della Repubblica. si precisava che oggetto del piano era la sistematica regolamentazione delle acque, ai fini sia della loro razionale utilizzazione, sia della lotta all' erosione del suolo e per la difesa del territorio contro le inondazioni. questa prima legge organica prometteva la definizione di un piano, che infatti fu presentato al Parlamento, ma non entro sei mesi, perché nessuno immaginava realizzabile in tale termine un piano del territorio, ma due anni dopo, nel 1954; già allora, in termini reali di quell' anno, il piano prevedeva 1.550 miliardi per i successivi dieci anni. seguì un periodo (dal 1955 al 1967) in cui furono varate leggi assolutamente sporadiche, intese a tamponare tutti i disastri che si verificavano nel paese; oppure si trattava di « leggine » per finanziare questo piano. abbiamo così, dopo i disastri della Calabria del 1953, il decreto legge di tamponamento del 1954; dopo Salerno, il provvedimento del 1954; dopo il Vajont, il provvedimento del 1963, e così via . dal 1955, si è proceduto tamponando fino al 1967. la « legge quadro » numero 632 del 1967 non è venuta fuori per interessi particolari della classe politica che, finalmente, in dieci anni aveva pensato che forse era meglio prevenire i disastri, comunque attrezzandosi per affrontarli piuttosto che procedere tamponando i danni economici e sociali registrati: no! questa legge del 1967 fu varata ad otto mesi di distanza dalla grande inondazione del 1966, che tutti ricordiamo, in conseguenza dello straripamento dell' Arno con i notevoli danni per Firenze. di fronte a quella gravissima inondazione di Firenze, si vara questa legge, che istituisce all' articolo 14 la famosa « commissione De Marchi » , che tutti ricordiamo; la commissione interministeriale doveva rivedere il piano di cui alla numero 184 per riaggiornarlo ed elaborare stime per un piano organico di difesa del suolo: si vara questa legge; si istituisce quella commissione, che lavora per due anni ed avanza una serie di proposte non più per la sola difesa idraulica del territorio, anche se quello resta il problema preminente, ma anche fornendo indicazioni su come non fosse possibile dimenticare nel nostro territorio, per una reale difesa del suolo, quei litorali che erano stati completamente trascurati dal primo piano . la « commissione De Marchi » presenta un suo piano, e quantifica in 9 mila miliardi per i successivi trent' anni i finanziamenti minimi per avviare un piano, un minimo decente ed un minimo credibile, per quanto riguarda il riassetto idrogeologico del territorio. però, come tutti i piani, anche questo è mancato nel modo più totale di finanziamento, tanto è vero che anche per il piano che prevedeva 1.500 miliardi — il piano famoso legato alla legge numero 184 la « commissione De Marchi » dichiarò che l' erogazione dei fondi è stata così limitata da non poter far fronte neppure alla manutenzione ordinaria. stando così le cose, l' assetto del territorio è andato sempre più degradandosi, e siamo arrivati alla legge del 1967, alla famosa « commissione De Marchi » . sempre nel 1967 pare che ci sia un sussulto di coscienza nei confronti di questo problema, tanto è vero che nello stesso anno viene presentato il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970. al capitolo 13 del programma economico nazionale si stabilisce finalmente che la politica generale di sviluppo economico che si intende stabilire richiede un' organica impostazione del problema della difesa e della conservazione del suolo. siamo così alla prima dichiarazione, negli atti, di questo problema; gli investimenti previsti sono di 900 miliardi, di cui 350 per opere idrauliche e circa 500 per le opere di sistemazione del suolo. faccio però notare che, proprio in quell' epoca, i danni calcolati per la sola alluvione di Firenze non erano inferiori ai 300 miliardi. quindi, il punto fermo era rappresentato da uno stanziamento di 900 miliardi, di cui 300 a tamponamento del problema dell' Arno e di Firenze; sarebbe, però, troppo pretendere che i residui 600 miliardi siano stati usati per il fine per cui erano stati stanziati, passando dalla fase dello stanziamento alla fase esecutiva. infatti, immediatamente dopo la pubblicazione della relazione della « commissione De Marchi » con la richiesta dei 9 mila miliardi per i prossimi trent' anni , il bilancio del 1971 stanziava, per questo specifico aspetto, 13 miliardi. nello stesso periodo vi fu una dichiarazione ben precisa del ministro Lauricella, il quale disse che con tale disponibilità non era possibile condurre una politica efficiente per la difesa del suolo, in un paese come il nostro che presenta una critica situazione idrogeologica. ebbene, non mi pare che dal 1971 ad oggi le cose siano molto cambiate. non è stato ripreso (e non è stata varata alcuna legge in proposito) un piano organico per la difesa del suolo, né è stato affrontato il problema nella nuova metodologia, in modo da non essere costretti ad intervenire soltanto dietro la spinta di interventi calamitosi, che certamente agitano tutti gli animi, ma che poi hanno la triste storia — passati cinque o sei mesi — di cadere nel dimenticatoio, semplicemente perché nel frattempo si è verificato un nuovo evento calamitoso e ci si deve occupare ormai di altro. quello che è venuto fuori, sia dalla commissione interministeriale, sia dalla legge del 1962, come dicevo, è che in effetti esiste — o è esistita — una capacità di programmazione, però neutralizzata da inerzie politiche reali, per cui non si perviene mai ad alcun risultato. anche la cifra stanziata dal piano quinquennale 1966-1970, che era, come ho detto, di 900 miliardi, di cui 300 per la sola Firenze (per lo straripamento dell' Arno), fu giudicata all' epoca da tutti gli esperti carente e, comunque, estremamente deficitaria. scopriamo invece dopo, esaminando i bilanci degli anni successivi, che non furono spese nemmeno quelle somme perché, pur riconoscendo che gli stanziamenti per la protezione del suolo non erano sufficienti, una volta stanziate le somme non vi fu alcuna volontà politica reale per utilizzarle. è per questo che, pur ritenendo oggi ancora insufficienti gli stanziamenti previsti nel fondo globale che sono 300 miliardi per il 1981, 500 per il 1982, mille per il 1983 — , siamo convinti che tali somme non verranno utilizzate. nel bilancio dell' anno scorso si previdero, per l' assetto idrogeologico del territorio, 158 miliardi, tutti passati nel capitolo concernente i residui passivi . in termini legislativi noi possiamo annoverare una serie di « leggi tampone » sui singoli eventi calamitosi, ma ancora non è stata varata una legge organica. ne fu presentata una nel 1978, dall' allora ministro Gullotti, che non concluse mai il suo itera causa della fine anticipata della legislatura. subito dopo ne fu presentata una analoga dal ministro Compagna. è stata ora presentata una nuova proposta organica — il disegno di legge numero 811 — dell' attuale ministro dei lavori pubblici Nicolazzi. questo provvedimento, presentato al Senato, per la prima volta tiene conto delle osservazioni degli addetti ai lavori mi riferisco all' ordine nazionale dei geologi — , quindi per la prima volta presenta una visione d' insieme del problema, in quanto tiene presente, oltre ai problemi delle acque, anche quelli dell' erosione del suolo. essa si occupa, inoltre, anche dello stato attuale dei servizi geologici dello Stato. al Senato è stato chiesto uno stralcio di tale disegno di legge e desidero esaminare gli articoli, oggetto di tale stralcio, perché ritengo che partendo da essi si possano svolgere alcune osservazioni che sono poi in larga parte desunte dalla relazione del Consiglio nazionale delle ricerche, che reca il titolo: commissione per l' esame dei disegni di legge sulla difesa del suolo. nella relazione che accompagna il disegno di legge numero 811, si fa riferimento alla cifra da stanziare, prevista in 100 miliardi per il 1981 e per complessivi 1.800 miliardi per gli anni 1982-1983. torneremo dopo sulla congruità dell' entità di questi stanziamenti; quello che mi preme sottolineare è che nella relazione del ministro si afferma che è necessario un flusso costante di finanziamenti, da assicurarsi attraverso i meccanismi della legge finanziaria . l' unica cosa che, invece, si trova nella legge finanziaria sono 12 milioni per le esigenze del servizio geologico — che credo abbia bisogno di un usciere, perché con quella cifra escludo che si possa assumere qualcun altro e poi vi sono 300 miliardi nei fondi globali che, come ben sappiamo, perseguono sempre strani fini: o non vengono utilizzati, come è accaduto l' anno scorso per i 158 miliardi destinati all' assetto idrogeologico, oppure vengono utilizzati per finanziare altre « leggine » di vario genere. la relazione del ministro insiste sul fatto che il problema reale è quello di inserire nella formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cioè nella legge finanziaria , questi fondi, in modo da non arrivare poi a situazioni in cui essi vengono a mancare ad opere già iniziate ed in situazioni in cui la ripresa dei progetti e la loro obsolescenza provocano un aggravio dei costi che non aiuta certo la soluzione del problema. dal Senato è stato unanimemente chiesto lo stralcio per accelerare i tempi. a prescindere che dallo stralcio vengono lasciate fuori le parti più interessanti di questo tentativo di legge organica per la difesa dei suoli, il testo che mi è stato dato — e che ora è in discussione al Senato — lascia completamente in bianco le cifre da destinarsi. faccio questa osservazione per dire che si tratta di una decisione politica che possiamo e dobbiamo prendere in sede politica, anche per dare indicazioni all' altro ramo del Parlamento su quale è la nostra volontà politica, cioè se intendiamo considerare il problema della difesa del suolo come elemento di politica organica e come voce di bilancio ordinario, oppure se intendiamo decidere che per il 1981 l' unico stanziamento debba ammontare a cento miliardi. se la proposta fatta dieci anni fa dalla commissione De Marchi era di 9 mila miliardi in trent' anni , considerando la svalutazione della lira, l' idea di stanziare cento miliardi per il 1981 è assolutamente ridicola. a questo aggiungiamo poi il degrado progressivo del territorio nazionale avvenuto in questi ultimi dieci anni, tanto è vero che l' ordine nazionale dei geologi ha rivalutato i 9 mila miliardi della commissione De Marchi a 30 mila miliardi attuali. a questa cifra — per l' aumentato degrado del territorio — essi stessi hanno aggiunto altri miliardi fino ad arrivare alla cifra definitiva di 50 mila miliardi per dieci anni: questa cifra viene anche ripresa dal Cnr. nelle valutazioni fatte dal Cnr, poi riprese da un comunicato del gruppo comunista del Senato, si osserva come sia difficile calcolare il costo reale per la collettività dei disastri degli ultimi dieci e vent' anni . sappiamo però quanti denari sono stati stanziati con i vari decreti-tampone per i soccorsi alle singole zone. si parla di una cifra che si aggira attorno ai 3 mila miliardi per l' ultimo decennio: questo per pure e semplici leggi-tampone ma per nessuna opera preventiva reale. la stessa relazione che accompagna questo stralcio che verrà discusso dal Senato dichiara: « si tratta, evidentemente, di risorse di per se stesse inadeguate a far fronte a così vasti obiettivi, ma che è assolutamente indispensabile mobilitare per l' avvio, di una programmazione » . siamo cioè in una situazione in cui interveniamo, per la prima volta, a 11 anni dalle segnalazioni della commissione De Marchi , con un progetto di legge che prevede per il 1981 appena uno stanziamento di 100 miliardi, che non sono sufficienti — e lo dice la stessa relazione che accompagna il provvedimento — neppure a portare a conclusione le opere in corso . in più questo stralcio propone, doverosamente, anche se in ritardo, una revisione del personale addetto ai servizi geologici dello Stato. parleremo dopo di questo problema, ma qui volevo solo segnalare che la stessa relazione che accompagna il provvedimento afferma che gli intenti previsti dal disegno di legge « non possono essere realizzati con le attuali disponibilità di personale nel ministero dei Lavori Pubblici che come ha ben evidenziato la relazione Giannini sono ridotte a livelli inammissibili » . credo che sia una politica estremamente miope quella di segnalare delle situazioni, senza poi farvi realmente fronte. io posso infatti anche plaudire all' iniziativa del ministro Nicolazzi, che ha presentato questo disegno di legge , che può essere condiviso, tranne nel punto sostanziale degli stanziamenti e della programmazione che è limitata a soli tre anni — questa previsione triennale dà, anch' essa, l' idea della miopia politica, perché in questo campo bisogna prevedere un piano che abbia un respiro più lungo — ma devo rilevare che tali contenuti non possono trovare un' operatività pratica con uno stanziamento di soli 100 miliardi per il 1981. credo che il povero ministro Nicolazzi, pure se otterrà lo stanziamento di 100 miliardi, potrà fare molto poco, perché non sarà neppure nelle condizioni di attuare il decentramento — previsto dalla legge — dell' istituto geologico dello Stato in termini interregionali, cioè nello stesso modo in cui si è decentrato il servizio idrografico, che è l' unico ad avere una struttura funzionale, perché la somma che noi stanziamo non è evidentemente sufficiente. i 100 miliardi, dunque, erano richiesti nel primo progetto di legge , mentre sono stati chiesti complessivamente 1.800 miliardi per gli anni 1982-1983. faccio notare, invece, che nella legge finanziaria non c' è una parola sul problema dell' assetto idrogeologico del territorio, tant' è vero che i nostri emendamenti si configurano come precisi articoli aggiuntivi. il disegno di legge finanziaria non prevede nulla, o meglio prevede solo i famosi 300 miliardi nei fondi globali e i colleghi che sono più bravi di me mi insegnano che i fondi globali sono il libro dei sogni di tutti, perché non hanno impegni reali di destinazione. abbiamo quindi presentato questa serie di articoli aggiuntivi « a scalare » , proprio per dare a tutti la possibilità di un giudizio reale sul problema. è vero che il terremoto è recente, è vero che i terremoti non possono essere evitati, ma bisogna stare anche attenti perché per le frane e le alluvioni lo stesso studio del CRN, che citavo prima, afferma che, seppure è vero che l' Italia ha una situazione orografica estremamente difficile, instabile, non essendo un territorio pianeggiante come il Nord Europa , è altrettanto vero che nel nostro paese, proprio per l' incuria totale, ormai ogni evento meteorologicamente più rilevante provoca dei danni incalcolabili. se guardiamo, ad esempio, solo le cifre, abbiamo, in media, una frana ogni 27 ore, un morto ogni otto giorni ed il 46 per cento dei comuni italiani interessati da fenomeni franosi o da fenomeni di dissesto del territorio. credo che queste cifre debbano far riflettere tutti, un po' più seriamente di quanto non sia stato fatto finora. se, ad esempio, guardiamo quali strutture dello Stato si occupino di questo problema, ci rendiamo conto che esse sono risibili, non solo ai nostri occhi — il che potrebbe essere poco o molto — ma anche a livello europeo. citerò ora dei dati che risalgono al 1977 ma che non sono molto diversi dagli attuali; mi auguro anzi che cambino con la proposta del ministro Nicolazzi, se mai giungerà in porto . voglio fare due soli esempi, il primo dei quali è quello del Servizio geologico d' Italia. vediamo intanto quali sono i compiti di questo povero istituto: rilevamento geologico del territorio nazionale , studi relativi ai materiali raccolti, pubblicazione delle carte rilevate, sia geologiche che tematiche, e degli studi inerenti, raccolta ed archiviazione dei dati geologici, consulenza geologica alla Pubblica Amministrazione , esecuzione di ricerche geofisiche, studio dei giacimenti minerari sotto l' aspetto geologico, studi di varia natura riguardanti i giacimenti di idrocarburi, raccolta ed ordinamento in collezione di rocce e di fossili e aggiornamento della biblioteca che, in materia, è una delle più grandi d' Europa. molto bene: questi sono i compiti di istituto. ma di essi ne vengono realmente svolti soltanto due: uno è quello del rilevamento geologico del territorio, l' altro dovrebbe essere quello della consulenza alla Pubblica Amministrazione . per quanto riguarda il rilevamento geologico del territorio, finalmente è stata pubblicata la carta geologica, il cui parto è durato cento anni: si è cominciato infatti nel 1870. potete immaginare come, a cento anni di distanza, questa risenta quanto meno di una obsolescenza di impostazione, dato che i criteri sui quali era stata impostata cento anni fa, provocano oggi in chi la deve usare alcuni problemi di utilizzo. in più è a scala 1: 100.000, per cui risulta inutilizzabile per chi se ne deve servire. il secondo compito di questo servizio geologico (vi dirò poi quanti geologi ha a disposizione) è quello della consulenza alla Pubblica Amministrazione . è evidente che, specie quando si tratti di opere pubbliche (mi riferisco in particolare alle autostrade), il parere, lo studio e la ricerca del geologo dell' ente statale dovrebbe rappresentare un dato di sicurezza nella ricerca e, soprattutto, di omogeneità nei criteri seguiti per tutto il territorio nazionale . tale attività di consulenza, sempre sollecitata in particolare dall' Anas, è stata svolta in percentuale molto ridotta, secondo il documento del 1977, in quanto il Servizio non poteva disporre, all' uopo, che di quattro o al massimo sei o sette geologi, perché l' organico del Servizio comprende 33 posti di geologo dei quali, tolti i geofisici, i dirigenti e i laboratoristi, restano 14 rilevatori e quattro geologi applicati. questo è l' organico sul quale ci muoviamo. non più decentemente, ma più o meno allo stesso livello di personale, si muove il Servizio idrografico, il quale però ha quanto meno una struttura decentrata, che oggi il Governo ci propone anche per l' istituto geologico e che, a mio avviso, dovrebbe essere adottata. anche qui però, come faceva rilevare la relazione Giannini, il personale è ridotto a livelli veramente assurdi, tanto che non può svolgere i compiti cui il servizio idrografico era destinato. ci troviamo quindi in una situazione in cui non è più possibile procedere con interventi marginali, perché in tal modo ci assumiamo la responsabilità precisa di non far nulla, cioè di affrontare il prossimo evento più o meno catastrofico in termini in cui il degrado del territorio farà sentire ancor più i suoi effetti. è vero che, come dicevo prima, l' Italia non ha una situazione facile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, che sono nettamente sfavorevoli a causa, da una parte, della degradazione meteorica e dell' alterazione chimica e fisica del terreno e dall' altra parte, a causa dell' erosione provocata dai corsi d' acqua nella parte montana dei loro bacini, con conseguente approfondimento del reticolo idrografico. è innegabile quindi che nell' aumento della franosità e dei danni alluvionali vi è un preciso ruolo della natura. quello che invece dobbiamo negare è che l' attività antropica, cioè l' attività dell' uomo, non abbia avuto e non abbia alcuna responsabilità nell' aggravamento dello stato di disastro effettivo, in termini di franosità, derivante dall' evacuazione dell' Appennino e in genere delle zone collinari del nostro paese, in cui si svolgeva il lavoro, certo modesto e artigianale, ma di grande importanza, dei contadini che curavano il terreno (basti pensare alle terrazze liguri), facendosi carico anche del problema del rimboschimento, o comunque del mantenimento di una situazione accettabile sotto tale profilo. l' abbandono di quelle zone si traduce, in termini statistici, nell' aumento degli episodi di franosità, con diversa intensità e gravità. anche se il calcolo credo pecchi per difetto (ma concorda con quello del Cnr), voglio citare l' indicazione contenuta nello studio del 25 ottobre 1979, di cui ci dà comunicazione il gruppo comunista della Camera, secondo cui per opere idrauliche, agrarie e forestali sono stati spesi duemila miliardi in vent' anni , dal 1952 al 1972. faccio notare che in soli dodici anni sono stati spesi seimila miliardi per autostrade. d' altra parte, dobbiamo anche notare che, quanto ad investimenti per la difesa del suolo, siamo scesi dalla percentuale dello 0,38 del reddito nazionale lordo del 1962 a quella dello 0,16 rispetto al 1972. c' è quindi un abbandono ed una deresponsabilizzazione, nonostante si disponga di tutti gli strumenti conoscitivi adeguati, come se ne disponeva già nel 1970. è stata svolta, successivamente, una nuova indagine da parte del Senato: conosciamo i dati relativi. credo che nessuno di noi o comunque nessuno che del problema si occupi possa dire di non essere stato a conoscenza dei termini del problema stesso e giustificare su tale base il mancato intervento. questa prima risposta che Nicolazzi ci presenta, ad undici anni di distanza dalla conclusione dei lavori della commissione De Marchi , può anche essere accettabile sotto il profilo teorico; credo però che si ripeterà anche sotto questo profilo quello che già è successo per altre leggi e per i relativi piani che, se pure accettabili in termini di programmazione teorica, in realtà non hanno mai ricevuto stanziamenti adeguati, per cui si è continuato con una gestione sporadica dei fondi a disposizione. a noi pare che la legge finanziaria dovrebbe segnare una svolta, e in questo senso proponiamo una serie di articoli aggiuntivi a scalare per iniziare una politica attiva e diversa per quanto riguarda il territorio. desidero soltanto ricordare, ad esempio, gli ultimi due disastri ferroviari che hanno colpito la regione calabra, dovuti a smottamenti del terreno, e tutti i danni che hanno provocato, non soltanto in termini economici e sociali, ma anche in termini di vite umane . credo che dovremmo avere il coraggio di iniziare una politica più impegnata da questo punto di vista e in questo senso la nostra volontà politica, al di là delle parole, si espliciterà attraverso lo stanziamento che noi prevederemo per risolvere questo problema. infatti, è troppo facile predisporre grandi piani che poi non verranno mai finanziati.
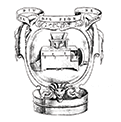 Accademia della Crusca
Accademia della Crusca